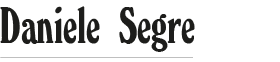Tullio Masoni e Paolo Vecchi / ed. Il lavoro editoriale ed. 2008
Questo testo è inserito in:
Angela Gregorini a cura di
UN’AMOROSA VISIONE. IL CINEMA DELLA REALTA’ FATTO DA RAGAZZE E RAGAZZI
Il lavoro editoriale ed. 2008
Nel corso di un interesse critico ventennale, ci è capitato più volte di soffermarci sul cinema di Daniele Segre, cercando di mettene in rilievo le costanti. Improntato alla coerenza e al rigore, il percorso del regista torinese si sviluppa tuttavia attraverso una serie di variazioni che con qualche azzardo potremmo definire minimali e che proprio per il loro progresso “a scalare” risultano talvolta di difficile lettura al primo impatto. Cinema pervicacemente aggrappato al reale, ma anche attraversato nel profondo dalla consapevolezza di una vigile mediazione linguistica, ci sembra abbia conosciuto un procedimento di frammentazione, rarefazione – astrazione diremmo quasi – nel corso degli anni. In virtù di esso, si è progressivamente accentuata la tendenza a cogliere i fenomeni sociali a partire dai loro protagonisti, da una sempre più scavata interiorità. Parallelamente, sul piano dei meccanismi narrativi, lo spazio della messa in scena si è sovente ristretto al volto, alla parola, addirittura al silenzio.
Schematizzando, il lavoro di Segre può essere diviso in due grossi tronconi. Il primo lo abbiamo chiamato cinema della fretta, rubando il termine allo Zavattini dei “Cinegiornali liberi”. In questo ambito, il regista si muove improvvisamente, talvolta in base a sollecitazioni di natura etico-politica, talaltra a quella vivacissima curiosità intellettuale che costituisce un dato fondante della sua personalità. Avutane notizia – dalla televisione, dalla radio, da un quotidiano -, si precipita nel luogo in cui gli eventi che lo hanno colpito si stanno dipanando. Al seguito, una ridottissima troupe messa insieme in poche ore, alle spalle una produzione affidata alla precarietà del volontariato, all’incerta prospettiva di una collocazione, mediatica o istituzionale, sempre comunque nell’ambito della marginalità. Il resto lo fanno istinto, esperienza, carica morale. Così Segre “entra” immediatamente nella situazione, inquadrandone i termini, individuando personalità e volti giusti, costruendo su di essi il filo conduttore di una storia che, per quanto oggettiva, mantiene comunque le stigmate della soggettività dell’autore.
Caso limite di questa metodologia è Ritratto di un piccolo spacciatore (1982), in cui un incontro casuale innesca la registrazione del torrenziale monologo di un junkie trafficante di eroina, una personalità forte e canagliesca che fa implodere tutti gli stereotipi sul fenomeno. Più spesso sono il mondo del lavoro e i suoi problemi a offrire il detonatore per l’intervento: è il caso di Crotone-Italia (1993) e Dinamite (1994), in cui la chiusura, rispettivamente di uno stabilimento e di una miniera, con la drammatica conseguenza della perdita del posto di lavoro, offre al regista l’opportunità per una serie di ritratti umani sbozzati con l’efficacia lancinante dello schizzo. Sulla stessa linea, Asuba de su serbatoiu (2001), sull’occupazione della Scaini a Villacidro in Sardegna, esibisce una diversa consapevolezza narrativa, in cui si mescolano epica e lirismo della sconfitta, affidata a una mdp insolitamente mobile che sembra quasi scoprire le installazioni industriali, aggirandosi attonita nel loro ventre in disarmo, mentre il paesaggio, il vento, il cielo e i tramonti ospitano con solennità fordiana i protagonisti della battaglia sindacale.
Il secondo blocco dell’opera di Segre potremmo denominarlo, paradossalmente ed e converso rispetto allo Zavattini sopraccitato, cinema della lentezza. Il racconto viene infatti costruito dopo un grosso lavoro preparatorio su un fenomeno, le sue radici, i suoi protagonisti, secondo una metodologia docu-fiction messa a punto qualche decennio fa in Ungheria dallo Studio Béla Balazs. Talora partendo da una commissione, talaltra seguendo un propria esigenza interiore, il regista srotola poi narrativamente il dato sociologico, trasferendolo sul piano della fiction e utilizzando con sensibilità unica le attitudini specifiche di ciascuno dei suoi non attori. Così, ad esempio, in Vite di ballatoio (1984), nato da una inchiesta sui transessuali pugliesi a Torino, i fili di ogni singola esistenza vanno a comporre un tessuto diegetico che ci introduce senza disagio anche nelle situazioni più lontane e diverse, valorizzando il talento in qualche caso istrionico dei singoli. E, in Pareven furmighi (1997), sulla costruzione di un cinema-teatro subito dopo la guerra da parte di un gruppo di di volontari, porta a compimento un lavoro che è anche di storia orale al di là del suo significato etico e simbolico, mettendo in scena gli antichi cooperatori con partecipe distacco, sfuggendo alle insidie del naturalismo della cronaca, alle lusinghe del colore locale e alla trappola del populismo, restituendoceli insomma nella loro verità di personaggi (1).
Momento alto in questo ambito, Tempo vero (2001), sui malati di Alzheimer, si propone come strumento di lavoro per sensibilizzare l’entourage delle persone affette da questo tipo di patologia. Gli imperativi della commissione, e la trama del successivo, minuzioso lavoro preparatorio con personale medico e congiunti dei malati, vengono organizzati da Segre in una struggente elegia che allegerisce le abituali geometrie di primi piani diversamente illuminati con un uso duttile della mdp e un discreto quanto efficace apporto della musica. L’acutezza dell’indagine si sposa alla pregnanza figurativa e simbolica, in una indicazione di poetica che vola alto, sopra gli opposti estremismi del “contenuto” e della cinefilìa autoreferenziale (2).
Questa premessa la facciamo per sottolineare la capacità di darsi da parte di Segre, di intendere il rapporto con il suo materiale narrativo – in senso umano, anche; e uomini sono ovviamente i suoi collaboratori “tecnici” – secondo una dinamica di continuo movimento, una vettorialità bidirezionale per cui, se l’ultima parola spetta sempre al regista, molteplici finiscono per essere gli apporti di coloro che gli stanno davanti e intorno. Il suo atteggiamento si caratterizza dunque come didattico, pure nell’esercizio di una estrema disponibilità che dovrebbe sempre accompagnare questa nobile missione. Al di là della prassi lavorativa, Segre lo ha istituzionalizzato, dapprima nell’indimenticata esperienza torinese che legava video e documentazione sociale, poi nella cattedra alla Scuola Nazionale di Cinema, o Centro Sperimentale che dir si voglia. Ma già in precedenza era solito prodursi in questa direzione, in situazioni che glie ne offrivano il destro. Personalmente lo abbiamo visto in azione in un corso per gli allievi e gli insegnanti delle superiori, organizzato a Piacenza da Pucci Piazza e Diego Mai per Teatro Gioco Vita. Il tema era, se ricordiamo bene, la sceneggiatura. A noi critici era ovviamente demandato l’aspetto – diciamo così – storico-teorico, cosa alla quale ci siamo applicati con diligenza e non senza un pizzico di divertimento e soggettiva arbitrarietà nella scelta delle sequenze “esemplari”. Precisi nello sviluppare un compitino che desse un’ idea passabilmente chiara della complessità, ma pur sempre “eunuchi nell’harem”, come diceva Kazan, che hanno nel migliore dei casi la finalità di spiegare come si disegna “un riconoscibile porcello in un riconoscibile porcile”, come scriveva Salinger.
Daniele Segre è successivamente passato come un ciclone sulle nostre deboli teste. Alle sue spalle c’era come sempre un percorso ben delineato, con direttrici, anche teoriche, già sperimentate. Ma tutto questo bagaglio si metteva quotidianamente – attimo per attimo, diremmo – in discussione di fronte alle persone, e alle situazioni che attraverso di esse si venivano determinando. Il rapporto tra lui e loro passava attraverso fasi, successive anche se non necessariamente scandite secondo una ordinata consequenzialità, in cui la fascinazione alta si alternava a suggerimenti sul piano più strettamente tecnico, la gratificazione non pretestuosa a rilievi che s’incattivivano talvolta nell’incazzatura (il carattere non è acqua, come si dice, e la generosità nel coinvolgimento sottintende la spontaneità in tutte le reazioni). Il risultato finale vedeva da una parte la selezione degli elementi migliori del gruppo, dall’altra la valorizzazione, in senso conoscitivo ma anche sul terreno pragmatico, realizzativo, di quanto di meglio erano capaci di esprimere anche i meno dotati.
Più che di rapporto didattico, dunque, vorremmo azzardare, socraticamente, il termine di maieutica per quanto abbiamo visto fare a Segre, e pochissime altre volte, purtroppo, in diversi ambiti scolastici, da noi frequentati sia da allievi che da insegnanti. In maniera indiretta, attraverso i risultati, questa capacità stimolatrice finalizzata alla creazione da parte del regista l’avremmo poi conosciuta grazie, ad esempio, a Me gh’era (1997), sorta di vivacissimo backstage di Paréven furmighi realizzato dai corsisti torinesi, e, in maniera più soggettivamente autoriale, in Echi di pietra (2003), intenso documentario sull’appennino reggiano in cui la bravissima Sara Pozzoli, diplomata in documentario alla Scuola Nazionale di Cinema con il regista, riesce persino nell’impresa di tenere a freno la smisurata proliferazione dell’ego dell’ex cantante dei CCCP e CSI Giovanni Lindo Ferretti, valorizzandone con grande sensibilità la conoscenza e l’amore dei luoghi, oltre all’indubbia presenza scenica e alle suggestioni di un volto antico.
Un particolare significato, nel lavoro svolto da Segre come didatta e sperimentatore a tutto campo, pensiamo vada poi attribuito all’esperienza che dal 2002 al 2005 egli ha vissuto, insieme a Morando Morandini e Antonio Costa, come direttore artistico di Anteprima Bellaria Film Festival. Un lavoro molto intenso, caratterizzato sia dalla fretta che dalla lentezza.
Quel Festival – nato nei primi anni ottanta nel segno della produzione indipendente,e subito inteso come occasione di confronto per i filmaker schiacciati dalla crisi – aveva cercato, fra molto altro, di dare concretezza a un’ambizione non nuova ma raramente confortata dalla pratica: agire sul territorio e stabilizzare attività permanenti. Fu lo stesso Morandini, introducendo l’edizione del 2004, a rilevarlo: «Quando nel 2002, dopo un quadriennio monarchico, il Bellaria Film Festival ritornò alla sua primitiva forma repubblicana, il nostro triumvirato si propose due obiettivi principali: 1) intensificare i rapporti di Anteprima con l’Università di Bologna,la Scuola Nazionale di Cinema di Roma e altri istituti universitari e cinetecari; 2) creare le premesse per dare inizio, nei fatti e non soltanto a parole, alle attività permanenti sul territorio per trasformare in una istituzione permanente un festival “mordi e fuggi”…». (3)
Valga in proposito, come esempio di metodo, Vestiti di vita(2004), il video nato da un laboratorio condotto da Segre con gli utenti del Centro Diurno per pazienti psichici Marco Polo di Terni (una sorta di “gioco-confessione” nel quale, basaglianamente e senza demagogia, i ruoli di sano e malato vengono scambiati); e valgano, nel senso proprio dell’attività territoriale permanente, lavori “figliati” dal Festival come Fotografia di un viaggio (2005) di Luca Bravi e Marina Santini – dal Centro di Riabilitazione Luce sul Mare (Bellaria Igea marina), 2005 – e Quando capita di perdersi (2005) di Sergio Basso – dalla Comunità di Sadurano (Forlì). Dal 2003 al 2005 – e davvero parliamo di un cinema della fretta o, se ci riferiamo al ruolo di stimolo, aiuto e supervisione ricoperto da Segre, di una didattica della fretta – studenti dell’Università di Pisa (Corso di laurea in Cinema, Musica, Teatro), della SNC e del Dams di Bologna hanno redatto il cinegiornale del Festival, Videomagazine, documentando giorno per giorno programma ed eventi. Un laboratorio allestito nei tempi strettissimi che richiede l’uscita giornaliera, nel quale la troupe doveva per forza di cose operare ecletticamente, ed esigere da se stessa il massimo di competenza possibile o, al contrario, esibire ogni limite, nella prospettiva di conoscere sempre meglio e in concreto la complessità del mestiere.
Un’esperienza tra la fretta e la lentezza (fretta per i tempi e le durate, lentezza per la profondità della sintesi)è poi quella del “cinema utile”; corti di dieci minuti al massimo, coi quali alcuni allievi di Segre alla SNC hanno riferito il loro approccio con una realtà urbana sofferente: la vita di una donna anziana che si dedica ai cani randagi dopo essere stata delusa dagli uomini, immigrati polacchi che vivono in grotte, un pensionato che si arrangia riciclando rifiuti metropolitani, una collaboratrice domestica con due figli a carico e una casa di 29 metri quadrati, che sogna di innamorarsi per essere finalmente portata a ballare… Flash in qualche caso eccellenti, nei quali l’impronta di Segre è riconoscibile dal segno nitido e dalla funzionalità della digressione.
A una programmatica lentezza, quella della messa in scena, vanno invece ricondotti gli esiti di un lavoro collettivo intitolato Viscere (2004), nel quale allievi della SNC delle cattedre di montaggio, sceneggiatura, regia e recitazione hanno affrontato un mezzo di inchiesta insolito e “artificiale” come il monologo.
Il rapporto con la realtà cercato dagli autori di questi preziosi cortometraggi (assai “eleganti” la fotografia, l’impiego delle luci, il chiaroscuro,l’espressività delle voci e la scelta dei piani)prende forma da una ricerca fondata sull’induzione e, muovendo da questa, dalla costruzione a posteriori sul set: il fatto reale resta sullo sfondo e la messa in scena, non estranea ai modi del kammerspiel – anzi concepita come una sorta di scommessa teorico-stilistica dove il teatro e il cinema si confrontano –, diventa del fatto stesso una suggestiva proiezione drammatica. Forse è dall’esperienza fatta con questo lavoro, potemmo azzardare, che ha preso le mosse Mitraglia e il Verme, la “bekettiana” tragedia realizzata da Segre nello stesso anno.
Con L’amorosa visione (2007) Segre compie un altro passo avanti, e non di poco momento, in questa direzione.
Come struttura portante, il film ricorda di primo acchito Partitura per volti e voci (1991), realizzato su commissione dell’Ufficio Nazionale di Formazione della CGIL. La scelta operata dal regista partecipa della stessa drasticità. Si tratta infatti di una serie di interviste ai delegati al congresso del più grande sindacato italiano, tutte affidate al primo piano, alla parola e alle variazioni di luce e fondali. Il discorso politico-sindacale si mescola a quello psicologico, e rimane come sospeso, senza interventi affermativi o sottolineature, trasudando implicitamente dai discorsi di ciascuno, nei quali dubbi e angosce investono sia il privato che l’ideologia.
Con L’amorosa visione il gioco si complica, aumentano le parti in causa e i livelli di intervento e mediazione. C’è infatti un primo lavoro di scrematura tra coloro che hanno imparato a usare il video, ce n’è uno successivo nella ricerca dei personaggi, la registrazione dei loro punti di vista, la scelta dei fondali, il montaggio…, il tutto sotto l’impulso di Segre, che immaginiamo presente ma sempre meno autoritario mano a mano che si procede e che ciascuno degli operatori acquisisce una coscienza in qualche modo professionale e, di conseguenza, qualche margine di autonomia.
Ovviamente, cambiano anche i temi affrontati, che sono relativi ai problemi, alle difficoltà e alle speranze degli intervistati, la cui età va dall’adolescenza alla giovinezza, dallo studio al primo impatto con il mondo del lavoro.
Ripercorrendo l’ormai lunga esperienza di Segre si rimane sorpresi dalla molteplicità di forme sulla quali il suo impegno si è misurato,dalla feconda inquietudine – quasi una febbre, un sintomo eccessivo di vitalità – e da una coerenza morale mai disgiunta dall’ambizione artistica.Uno dei giovani protagonisti di Amorosa visione, riferendosi al lavoro e all’autenticità testimoniale che in esso lievita,ha pronunciato la parola utopia;una parola abusata, forse, ma che nel nostro caso può tornare utile. Come definire diversamente quel correre, quel cercare l’espressione fra immediatezza, pensiero e memoria, quella vocazione sperimentale? Per vie dirette, o attraverso la didattica, Segre ha perseguito l’utopia del dire e del mostrare con verità (esaltando il rischio di un approccio inevitabilmente parziale ) contro la pornografia tele-giornalistica imperante e senza chiudersi in una maniera. La sua, dunque, è l’utopia di chi rivendica il primato dell’idealità e lo vive in unione stretta col lavoro.E, anche, di chi concepisce la concretezza del comunicare come una preziosa e necessaria occasione poetica. Con la sua ironia elegante, in un’intervista di parecchi anni fa, Resnais attribuiva all’amico e collaboratore Chris Marker il dono dell’ubiquità: opera in posti diversi nello stesso momento ma non lo si incontra quasi mai. Per Segre è un po’ lo stesso: non sappiamo con precisione in cosa sia impegnato e dove, ma sappiamo con certezza che lavora e che, presto,ce ne darà conto.
NOTE
1)Entrambi i film si caratterizzano per intrusioni schiettamente comiche, alle quali il regista si abbandona con felicità. Più in generale, abbiamo dimostrato con abbondanza di pezze giustificative che, nemmeno tanto paradossalmente, esiste un registro di commedia pressoché in tutto il cinema severo di Daniele Segre.
2) In fondo, anche il cinema di finzione del regista funziona allo stesso modo. Manila Paloma Blanca (1992), ad esempio, nasce dall’incontro di Segre con Carlo Colnaghi, un ex attore del “Piccolo” che aveva <
3) Si va avanti, con qualche novità, Catalogo del Bellaria Film Festival, Comune di Bellaria Igea Marina,2005, pag.5